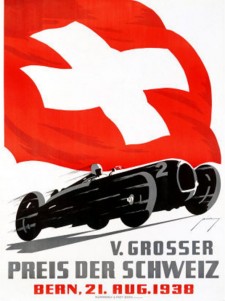Come si può facilmente dedurre, il Monaco 1860 deve il nome all’anno della propria fondazione, anche se all’epoca non era ancora altro che una polisportiva di ginnastica e atletica. Per l’avvento del calcio si sarebbero dovuti aspettare altri quarant’anni, precisamente il 1899. Poi, solo un anno dopo, da un gruppetto di diciotto dissidenti della società di ginnastica Münchner TurnVerein avrebbe visto la luce il Bayern.
Come si può facilmente dedurre, il Monaco 1860 deve il nome all’anno della propria fondazione, anche se all’epoca non era ancora altro che una polisportiva di ginnastica e atletica. Per l’avvento del calcio si sarebbero dovuti aspettare altri quarant’anni, precisamente il 1899. Poi, solo un anno dopo, da un gruppetto di diciotto dissidenti della società di ginnastica Münchner TurnVerein avrebbe visto la luce il Bayern.
Col passare dei decenni l’ingombrante presenza del Bayern ha creato un complesso d’inferiorità nei tifosi della più antica squadra di Monaco di Baviera. Ma almeno fino alla seconda guerra mondiale il 1860 era ancora la squadra più popolare della capitale bavarese, mentre il Bayern raccoglieva i propri simpatizzanti soprattutto in provincia. Godendo della compiacenza dei gerarchi nazisti, il 1860 aveva conosciuto negli anni trenta una fase di successo, fino all’apice della conquista della Coppa di Germania nel 1942. Sarà poi il dopoguerra a generare un nuovo complesso, quello di colpa, nei suoi sostenitori e nei suoi dirigenti: complesso tanto vivo e vegeto tuttora, al punto di far rimuovere integralmente gli anni del Terzo Reich dalla sezione storica del sito ufficiale della squadra.
L’epoca d’oro del Monaco 1860 comincerà negli anni sessanta e durerà per tutto quel decennio, sotto la guida dell’allenatore austriaco Max Merkel, per coronarsi in tre splendide annate: il 1964 con la conquista della seconda Coppa di Germania, il 1965 con l’approdo alla finale (poi persa) di Coppa delle Coppe, e il 1966 con la prima ed unica vittoria in campionato della propria storia. Ma la fortuna volgerà presto le spalle ai “leoni”, come vengono anche chiamati per via del loro stemma raffigurante un leone rampante. Alla fine del 1969 il bilancio societario comincia a presentare le prime crepe, con un’esposizione debitoria di oltre due milioni di marchi. E come una tegola, nel 1970 si abbatte anche l’onta della retrocessione in Zweite Bundesliga, la seconda divisione del campionato tedesco, con una conseguente emorragia di pubblico e di incassi.
Gli anni settanta erano stati anni di difficoltà finanziarie per tutto il calcio tedesco, e persino il cancelliere socialdemocratico Helmut Schmidt era dovuto intercedere presso le banche per salvare dalla bancarotta l’Amburgo, la sua squadra del cuore. Dall’altra parte della barricata, Erich Riedl, uno dei maggiorenti della CSU, il partito conservatore alla guida della Baviera, era diventato il presidente del Monaco 1860, ed aveva utilizzato la propria influenza nel governo locale per mendicare finanziamenti.
Come sperato, gli aiuti erano arrivati a destinazione, e il Monaco 1860 era potuto ritornare in prima divisione; ma in cambio la dirigenza del club aveva assunto una forte connotazione politica. E questi politici, anche se tutti appartenenti alla CSU, avevano cominciato a litigare tra loro come tanti galli nello stesso pollaio. A questo si era poi aggiunta una campagna acquisti tanto dispendiosa quanto infruttuosa, che alla fine degli anni settanta aveva dissanguato il club, fino a spingerlo al fallimento nel 1982.
A causa del fallimento si era dovuto dire addio col fazzoletto agli occhi alla ribalta della Bundesliga per ripartire da zero, ossia dai campionati regionali bavaresi: un purgatorio dove il Monaco 1860 avrebbe languito lungo tutti gli anni ottanta. La rimonta sarebbe arrivata nel decennio successivo, ed sotto la guida di un nuovo rampante e spregiudicato presidente, Karl Heinz Wildmoser, di professione imprenditore nel campo della ristorazione. Così, per la gioia dei tifosi, a fine anni novanta la seconda squadra di Monaco sarebbe rientrata in prima divisione, fino a guadagnarsi anche una fugace comparsata nella fase preliminare della Champions League del 2000.
I problemi finanziari ricompaiono però nella prima metà degli anni duemila, in concomitanza con la preparazione dei mondiali di Germania 2006, quando viene deliberata la costruzione di un nuovo avveniristico stadio a Monaco: il futuro Allianz-Arena. I costi della nuova struttura sono esorbitanti: 340 milioni di euro, e vengono sostenuti da una società costituita pariteticamente dal Bayern e dal Monaco 1860, con il figlio di Wildmoser, Heinzi, sullo scranno di amministratore delegato.
Se per il Bayern, coi suoi oltre 150mila soci, 2.500 fans club sparsi per il mondo, e un’attività internazionale di merchandising straordinariamente redditizia, non è stato un problema reperire i fondi necessari, per i cugini del Monaco 1860 l’investimento si è rivelato un salasso in piena regola. Un escamotage per sovvenzionare le aziende di famiglia lo avevano trovato invece i Wildmoser padre e figlio, che nel marzo del 2004 verranno arrestati per essersi intascati tangenti dalla società costruttrice dello stadio per circa 2 milioni e 800mila euro. Anche se poi il padre e presidente patriarca della squadra verrà scagionato dalle accuse (peggior sorte si abbatterà invece sul giovane Heinzi, condannato a quattro anni e mezzi di galera), dovrà subire la defenestrazione dalla presidenza della squadra. Per il Monaco 1860, retrocesso contemporaneamente in Zweite Bundesliga, significherà la fine di un percorso e l’imbocco di un tunnel.
Inevitabilmente, nel 2006 la nuova amministrazione aveva comunicato di essere rimasta con le casse vuote, impotente a raccogliere i 12 milioni di euro necessari a pagare le licenze alla federazione per proseguire l’attività. Urgeva una misura estrema, una di quelle a cui l’orgoglio del club non avrebbe voluto ricorrere mai: chiamare in soccorso i cugini e rivali del Bayern. E questi, anche se di malavoglia, avevano risposto alla chiamata, acquistando la quota di capitale del Monaco 1860, ossia il 50%, nella Allianz Arena Gmbh, la società incaricata della gestione dello stadio. La bancarotta era scongiurata, ma solo temporaneamente. E proprio il mese scorso il nuovo presidente ha annunciato un’ennesima emergenza: casse nuovamente vuote e, senza più i gioielli di famiglia da poter mettere in vendita, urgenza di procacciarsi un finanziatore, possibilmente disposto a devolvere pronta cassa almeno 10 milioni di euro.
Si è ricorso ancora all’aiuto dei cugini, che però questa volta hanno voltato le spalle dispiaciuti; si è implorato l’aiuto del land della Baviera, che però si è dovuto tirare indietro, adducendo il divieto comunitario sugli aiuti di stato, finché la scorsa settimana è comparso, o meglio è sembrato apparire dal nulla l’atteso cavaliere bianco. Ë un giordano di 34 anni, ma non assomiglia neanche lontanamente a Lawrence d’Arabia. Si chiama Hasan Abdullah Ismaik, e allo stato attuale sembra seriamente intenzionato ad acquisire il 49% del capitale del centocinquantenario club monacense (per la legge tedesca il 50% + 1 delle azioni delle squadre di calcio della Bundesliga devono restare di proprietà del club stesso).
E se l’uomo d’affari giordano si dovesse tirare indietro, per il Monaco 1860 le speranze di salvarsi dal secondo fallimento della propria storia si ridurrebbero ai minimi termini. A tutt’oggi il temuto ritorno ai campetti delle divisioni regionali nel prossimo campionato non è ancora scongiurato.