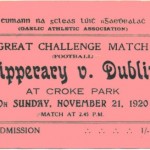Novanta anni fa, una partita qualunque di football gaelico si macchiava di sangue.
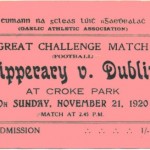 “Beh, allora? Testa o croce?”. Secondo una leggenda mai provata fino in fondo, quel giorno i militari inglesi si sfregano le mani: non importa quale faccia della moneta verrà restituita dal lancio in aria, gli irlandesi la pagheranno cara, in quella domenica di fine novembre del 1920. Da qualche anno i rapporti tra l’Irlanda e la corona si sono irrigiditi: il Parlamento britannico approva l’Home Rule, riconoscendo così l’autogoverno dell’isola dei celti, mentre in Europa divampa la Prima guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto porta al rinvio dell’entrata in vigore dell’atto e contribuisce ad innervosire gli animi: il 1916 è l’anno dell’Easter Rising, la Rivolta di Pasqua, una ribellione armata di sei giorni sedata duramente dagli inglesi. Lo scontro tocca l’apice con le elezioni del 1918, le prime con la nuova riforma elettorale che estende il diritto di voto anche alle donne ultratrentenni: il Sinn Féin, partito nazionalista irlandese, ottiene 73 seggi in Parlamento ma i suoi militanti si rifiutano di sedere sugli scranni di Westminster. Decidono, invece, di costituire un’assemblea irlandese – il Dáil Éireann – ed un proprio governo – l’Aireacht, guidato da Éamon de Valera: entrambi gli organi proclamano l’indipendenza dell’isola. Si apre, così, il conflitto anglo-irlandese, del quale la Bloody Sunday del 21 novembre 1920 costituisce una tappa cruciale.
“Beh, allora? Testa o croce?”. Secondo una leggenda mai provata fino in fondo, quel giorno i militari inglesi si sfregano le mani: non importa quale faccia della moneta verrà restituita dal lancio in aria, gli irlandesi la pagheranno cara, in quella domenica di fine novembre del 1920. Da qualche anno i rapporti tra l’Irlanda e la corona si sono irrigiditi: il Parlamento britannico approva l’Home Rule, riconoscendo così l’autogoverno dell’isola dei celti, mentre in Europa divampa la Prima guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto porta al rinvio dell’entrata in vigore dell’atto e contribuisce ad innervosire gli animi: il 1916 è l’anno dell’Easter Rising, la Rivolta di Pasqua, una ribellione armata di sei giorni sedata duramente dagli inglesi. Lo scontro tocca l’apice con le elezioni del 1918, le prime con la nuova riforma elettorale che estende il diritto di voto anche alle donne ultratrentenni: il Sinn Féin, partito nazionalista irlandese, ottiene 73 seggi in Parlamento ma i suoi militanti si rifiutano di sedere sugli scranni di Westminster. Decidono, invece, di costituire un’assemblea irlandese – il Dáil Éireann – ed un proprio governo – l’Aireacht, guidato da Éamon de Valera: entrambi gli organi proclamano l’indipendenza dell’isola. Si apre, così, il conflitto anglo-irlandese, del quale la Bloody Sunday del 21 novembre 1920 costituisce una tappa cruciale.
La lunga domenica di sangue a Dublino inizia con il sorgere del sole: di buon mattino, le squadre dell’IRA (Irish Republican Army) entrano in azione. Il piano è già predisposto: il capo dell’intelligence, nonché ministro delle finanze dell’Aireacht, Michael Collins ordina l’assassinio di alcune spie inglesi presenti in città. In particolare, l’attenzione è rivolta alla Cairo Gang, un gruppo di diciotto alti ufficiali britannici che hanno prestato servizio per Sua Maestà in Egitto e Palestina e che vorrebbero infiltrarsi nell’organizzazione di Collins: nessun dubbio, sono loro il bersaglio da colpire. Con la complicità di alcune domestiche e grazie alle soffiate di un poliziotto della RIC (Royal Irish Constabulary), gli uomini di Collins riescono a scovare il domicilio di numerosi agenti britannici: la maggior parte di essi è localizzata in un sobborgo meridionale di Dublino. All’alba iniziano le operazioni, che portano all’omicidio di quattordici persone, tra cui due appartenenti alla Divisione Ausiliaria, quattro ufficiali dell’intelligence britannica ed altrettanti agenti dei servizi segreti: sono meno della metà dei trentacinque nomi finiti sulla lista nera, ma la notizia scuote l’intelligence britannica presente in Irlanda. E la vendetta non tarda ad arrivare.
“Beh, allora? Testa o croce?”. Le truppe inglesi stanno predisponendo il contrattacco. Due le alternative: o si mette a ferro e fuoco Sackville Street, oppure si fa irruzione a Croke Park, cattedrale del football gaelico. Testa o croce. Croce. In tutti i sensi. Nonostante il clima di tensione, cinquemila – anzi, diecimila secondo altre fonti – persone si dirigono allo stadio: i locali del Dublino affrontano la squadra di Tipperary (nella foto a sinistra, il biglietto della partita). Iniziato alle 15.15, con mezzora di ritardo, l’incontro viene interrotto dopo dieci minuti: è in quell’istante che i Black and Tans, un gruppo paramilitare britannico, forzano i tornelli dell’entrata da Canal End e irrompono sul campo di gioco, spalleggiati all’esterno da truppe della RIC e della Divisione Ausiliaria. I militari aprono il fuoco sulla folla, sparando per novanta, interminabili secondi. Gli spettatori, in preda al panico, fuggono terrorizzati: alcuni di loro provano a mettersi in salvo scavalcando il muro della tribuna Canal End, altri si dirigono verso l’altra estremità dello stadio, gli ingressi su Clonliffe Road. Ad attenderli c’è un altro cordone di militari, supportato da un’autoblindo che lascia partire altri proiettili sopra le teste della folla impaurita. Per un macabro scherzo del destino, Londra restituisce il colpo a Dublino: quattordici le vittime del mattino, quattordici le vittime del pomeriggio. Al Croke Park sono sette le persone crivellate, mentre cinque vengono ferite mortalmente e, infine, altre due muoiono calpestate dalla folla in fuga: la morte si porta via due bambini di appena 10 e 11 anni e Jeannie Boyle, una ragazza che si era recata alla partita in compagnia del fidanzato che, cinque giorni dopo, l’avrebbe dovuta portare all’altare. Anche lo sport piange: rimangono a terra Jim Hegan del Dublino, che riesce tuttavia a sopravvivere, e Michael Hogan, capitano del Tipperary, che invece non viene risparmiato dai proiettili. Ed è proprio a lui che, qualche anno dopo, verrà intitolata una delle tribune del Croke Park. Ma gli irlandesi non hanno ancora finito di versare sangue: due alti ufficiali dell’IRA, Dick McKee e Peadar Clancy, assieme all’amico Conor Clune vengono portati al Castello di Dublino, quartier generale inglese sull’isola. Qui subiscono torture e muiono in circostanze misteriose. Il numero delle vittime sale, così, a trentuno. L’Irlanda paga con il sangue di alcuni suoi figli la sollevazione nei confronti dell’Inghilterra, ma la tragica vicenda segna le menti dell’opinione pubblica: la credibilità del Regno Unito sullo scenario politico internazionale ne esce a pezzi, il sostegno al governo repubblicano di de Valera si fa sempre più forte.
L’escalation di violenza prosegue per oltre un anno, fino all’11 luglio 1921, quando viene firmata la tregua e lo Stato Libero d’Irlanda viene riconosciuto da Londra come dominion, una comunità cioè associata all’impero britannico ma con poteri autonomi ed un proprio Parlamento. Nel frattempo la GAA, l’associazione che promuove e coordina gli sport gaelici, vieta agli appartenenti alle truppe britanniche o alle forze dell’ordine nordirlandesi di assistere a eventi sportivi organizzati dalla GAA stessa. Al contempo, fa sì che gli sport “stranieri” e, nella fattispecie, britannici – ad esempio calcio e rugby – non possano essere giocati negli impianti della GAA come il Croke Park. Le conseguenze più importanti, però, si hanno in ambito giudiziario: due corti militari aprono immediatamente l’inchiesta sui fatti del 21 novembre e, in poco più di due settimane, emettono un verdetto. Il governo britannico, però, fa sparire le carte processuali, rimaste nascoste per oltre ottanta anni: una volta rinvenute – dieci anni fa – è stato possibile venire a conoscenza della sentenza. E cioè che il fuoco aperto sulla folla dagli inglesi era da considerarsi un gesto indiscriminato ed ingiustificabile e, soprattutto, veicolato senza alcun ordine superiore. Resta, ancor oggi, qualche dubbio su chi abbia effettivamente iniziato gli spari a Croke Park tra gli uomini dell’IRA e le truppe al servizio della Gran Bretagna (qui trovate tutte le ricostruzioni e numerose testimonianze). Ma sul sangue che scorreva a fiotti in quella maledetta domenica, no, non v’è dubbio alcuno.
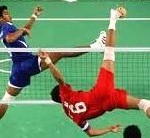 L’evoluzione degli sport dei Giochi d’Asia rispecchia la sempre maggior centralità del continente nello scacchiere mondiale, non solo a livello economico e militare ma anche a livello culturale. Se alle Olimpiadi, ancora dominate da un’élite conservatrice europea, gli sport di origine non-occidentale si contano sulle dita di una mano, nei Giochi d’Asia aumentano di quadriennio in quadriennio. Nel 1951 le competizioni in programma erano tutte di origine occidentale; solo nel il sollevamento pesi alcuni paesi asiatici potevano vantare una certa tradizione. Tra il 1954 e il 1962 furono inseriti alcuni sport come la lotta, l’hockey su prato, il tennistavolo e il badminton che pur essendo di origine europea avevano un’importante diffusione in Asia. Dalla metà degli anni Sessanta a quella degli anni Ottanta furono aggiunti nel programma esclusivamente sport olimpici di origine occidentale. Nel 1986 spinti dal crescente peso politico-economico delle tigri asiatiche fecero il loro ingresso lo sport nazionale giapponese, il Judo, e quello coreano, il taekwondo.
L’evoluzione degli sport dei Giochi d’Asia rispecchia la sempre maggior centralità del continente nello scacchiere mondiale, non solo a livello economico e militare ma anche a livello culturale. Se alle Olimpiadi, ancora dominate da un’élite conservatrice europea, gli sport di origine non-occidentale si contano sulle dita di una mano, nei Giochi d’Asia aumentano di quadriennio in quadriennio. Nel 1951 le competizioni in programma erano tutte di origine occidentale; solo nel il sollevamento pesi alcuni paesi asiatici potevano vantare una certa tradizione. Tra il 1954 e il 1962 furono inseriti alcuni sport come la lotta, l’hockey su prato, il tennistavolo e il badminton che pur essendo di origine europea avevano un’importante diffusione in Asia. Dalla metà degli anni Sessanta a quella degli anni Ottanta furono aggiunti nel programma esclusivamente sport olimpici di origine occidentale. Nel 1986 spinti dal crescente peso politico-economico delle tigri asiatiche fecero il loro ingresso lo sport nazionale giapponese, il Judo, e quello coreano, il taekwondo.